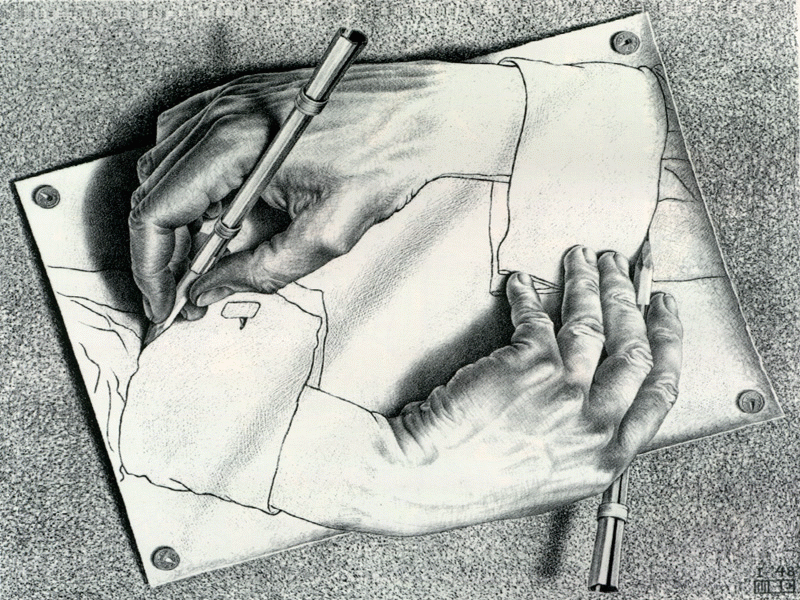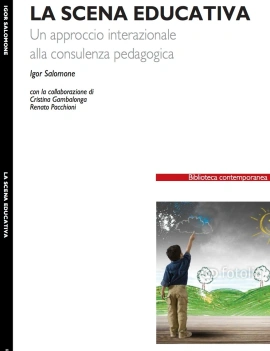Di Igor Salomone
(Occhio, il post è pieno di SPOILER. Se avete intenzione di andare a vedere il film senza i miei commenti in testa, fermatevi qui. Altrimenti, buona lettura)
Non riesco da anni a vedere un film o una serie senza leggerli in salsa pedagogica. Figuriamoci se il film o la serie sono esplicitamente focalizzati su temi educativi. Per questo ho avvertito una certa resistenza nell’infilarmi al cinema per vedere “La sala professori”. Niente da fare, soffro di una vera e propria compulsione che mi ha costretto ad analizzarne le dinamiche educative.
Ovvio, direte voi, il set è una scuola, media suppongo, e i personaggi sono professori, presidi, personale, studenti, genitori. Cos’altro avrei mai dovuto vederci? Ma la vicenda può essere narrata in modo molto standard, tipo: i rapporti difficili tra un’insegnante di matematica e la sua classe e i dilemmi educativi che sorgono quando l’insegnante tenta di scagionare i ragazzi dalle accuse implicite di essere gli autori di alcuni furti avvenuti a scuola. I furti sembrano compiuti nella sala professori e l’insegnante cerca di verificare chi può essere stato scegliendo una tattica inaudita: gira un video con il computer che sembra tirare in causa la segretaria della scuola. Da qui le cose precipitano e inizia un tutti contro tutti: alunni contro alunni, preside contro insegnanti, genitori contro insegnanti e, sopratutto, tutti contro l’insegnante di matematica. In ballo ci sono il rispetto dell’Autorità versus il rispetto dei ragazzi che i ragazzi stessi rivendicano. Per non parlare del conflitto feroce scoppiato tra l’insegnante protagonista e la segretaria presunta colpevole. Conflitto che scatena in parallelo un conflitto ancor più pesante con il figlio della segretaria, alunno dell’insegnante di matematica.
Insomma, un casino. Ma la ciccia pedagogica dov’è? Sì certo, il gioco dei valori, il rispetto di ognuno per tutti contrapposto alla “tolleranza zero” sostenuta dalla Preside. Una lettura standard del fenomeno educativo, appunto. E anche piuttosto noiosa, di quelle viste e straviste in mille narrazioni simili. Alla fine si riduce tutto a un gioco di relazioni che conduce a imbuto alla centralità della relazione educativa tra l’insegnante protagonista e il suo alunno, figlio della presunta ladra. Per dirla con i più, la relazione educativa fondata sull’ascolto e l’empatia alla fine vince in un tripudio di emozioni, con la ricollocazione al centro della vicenda del ragazzo-alunno-figlio, portato in trionfo nella scena finale su una sedia sostenuta a spalle da due poliziotti.
Rrronffff…
(Nel secondo episodio: perchè il titolo è fuorviante, che struttura emerge in filigrana dalla vicenda, cosa sceneggiatori e regista hanno raccontato veramente, probabilmente senza neppure saperlo, ma sarebbe interessante chiederglielo)