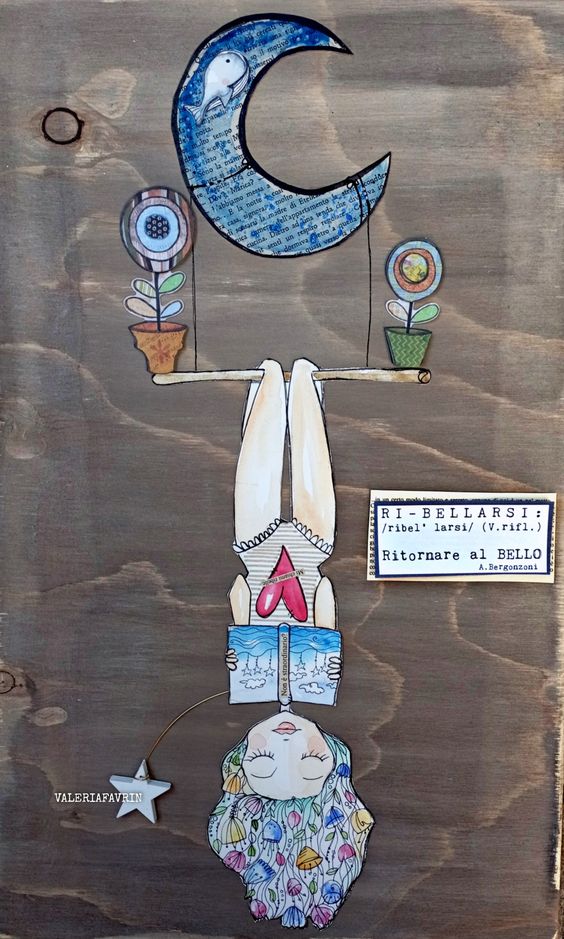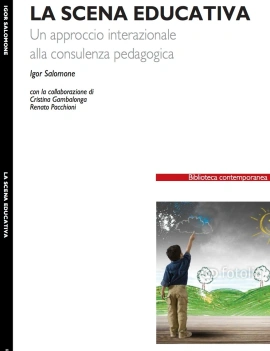di Irene Auletta
Stamane inizia una settimana di centro estivo Tma (terapia multisistemica in acqua), ricco di proposte e di belle iniziative.
Durante i preparativi della mattina sei attenta e curiosa ma in auto, nel tragitto verso il Centro, diventi subito seria e, giunta a destinazione esprimi, come fai sempre, la tua ambivalenza tra andare e resistere.
E’ facile confondere questo comportamento eguagliandolo a quello dei bambini piccoli e ci vuole ogni volta forza, costanza e competenza, per guardare altrove.
In una vita dove e’ difficile, se non impossibile, prefigurarsi i cambiamenti, risultano particolarmente importanti il rispetto dei tempi e i relativi necessari assestamenti. L’equilibrio tra l’attesa e la sollecitazione però, per me, non e’ affatto cosa semplice perché spesso ti vedo imprigionata nella difficoltà di andare oltre la tua stessa “presa di posizione” e allora la sensazione di forzare, a volte, sembra prendere il sopravvento sulla tua volontà.
E così, con un po’ di disagio nello stomaco e le solite domande spalancate ti lascio al cancello mentre mi guardi serissima, ancora indecisa sul farti convincere ad entrare. Se tu sei ambivalente in queste situazioni io lo sono ancora di più, al limite del dissociata. La testa mi richiama con fermezza alla tua età, al bisogno di proteggerti meno e di forzare un po’ la mano, mentre il cuore mi trova sempre un po’ smarrita e incerta.
Tante volte, pensando ai genitori dei bambini piccoli, ho detto che vanno accolti con delicatezza e pazienza, come “genitori piccoli” che devono ancora crescere nel loro ruolo. I genitori con figli disabili adulti, pur non essendo genitori piccoli, molto spesso riflettono la fragilità dei loro figli e penso vadano trattati con cautela, riconoscendo dietro apparenti fermezze, insicurezze ed emozioni tanto delicate.
Si, anche ora io mi vedo proprio così come un tuo riflesso, mentre guardo emozionata la foto ricevuta, che trattiene il divertimento e l’allegria.
Ombra e luce. Destino imprescindibile della relazione con te. E poi, ombra e luce non sono i volti della Luna?