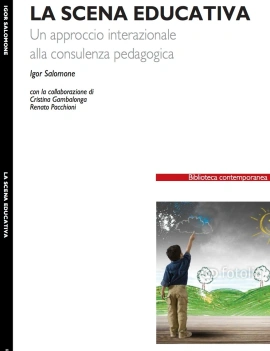di Irene Auletta
Se penso ad una delle parole che negli ultimi anni ricorre frequentemente nel mio lavoro con gli operatori e con i genitori, mi pare di non avere alcun dubbio.
Il vocabolario Treccani la definisce così. Sforzo materiale che si fa per compiere un lavoro o svolgere una qualsiasi attività, e di cui si sente il peso e poi la stanchezza.
Avete già capito vero? La parola è fatica.
Che fatica, sono in fatica, periodo molto faticoso, sono solo alcuni degli incipit con cui molte volte iniziano gli scambi comunicativi e che ogni volta, ormai da molti anni, mi portano a farmi nuove domande per capire, andando alla ricerca di significati possibili capaci di guardare oltre il muro della lamentela che troppe volte definisce il tono e le sfumature delle comunicazioni.
Pensando alla mia storia educativa, penso immediatamente a mia madre e alla sua incredibile capacità di trasformare le fatiche in un valore perchè il gusto era indubbiamente nel risultato, nella raccolta e in quella soddisfazione finale che concentrava l’attenzione, alleggerendo tutto ciò che veniva prima. La ringrazio ogni giorno per questa preziosa eredità perchè la vita finora non mi ha fatto molti sconti e non sembra neppure intenzionata a modificare questa sua direzione.
Grazie a mia madre, anche nei momenti di maggiore sconforto, appena riesco, vado alla ricerca di ciò che ogni fatica può riservarci rinnovando, insieme al nutrimento della speranza, il gusto per le nuove possibilità.
Grazie a mia madre provo a insegnare lo stesso a mia figlia che è arrivata al mondo con uno zainetto talmente pieno di fatiche che ogni tanto mi chiedo se non ci sia stato davvero un grossolano errore nella distribuzione. Infatti, oltre a non apprezzare per nulla i termini bellici guerriera o guerriero, oggi peraltro stra abusati, penso che non restituiscano giustizia né comprensione alle condizioni di vita come la tua e alle continue prove quotidiane.
Eppure ti vedo felice, tenace, resistente, curiosa, appassionata. Insomma ti vedo piena di vita. Vuoi dire che un po’ della preziosa eredità della nonna sta arrivando fino a te, trasportata da quei fili invisibili coltivati nel nostro straordinario, complesso, meraviglioso, difficile incontro?
Credo che la ricerca vada proprio orientata verso ciò che accade dopo il momento o la situazione definita faticosa. Cosa ha permesso di imparare, di scoprire, di darci la forza e la spinta per proseguire a testa alta? Cosa può aiutarci a non smarrire, e continuare a coltivare, i piccoli attimi di felicità? Cosa possiamo insegnare ai bambini e ai ragazzi in questi delicati attraversamenti?
A me aiuta ricordare che più abbassiamo lo sguardo e ci ripieghiamo su noi stessi, più non vediamo oltre la punta dei nostri piedi, smarrendo qualsiasi gusto e interesse per ciò che ci circonda e, a volte, per la vita stessa.
Per questo, ogni volta che inciamperai, materialmente o metaforicamente, io spero di continuare ad essere lì finche potrò, solo per ricordartelo.
Alza la testa Luna, guarda in alto, guarda che bello, guarda il mondo!