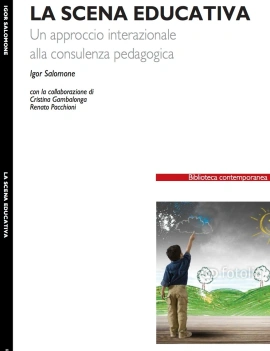Ricevo questa bella recensione del mio romano L’eredità spezzata da parte di un’amica di sempre. Compagna in gioventù di militanza e tante battaglie e in età adulta di un percorso professionale e formativo che ha fatto dell’educazione l’ordito comune delle nostre trame esistenziali. Sono felice sia lei a fare da apripista di un percorso che spero accoglierà molte altre voci.
Non preoccupatevi comunque, non ci sono spoiler 🙂. E quei pochi che si intravedevano, li ho censurati…

Ancora una volta
di Nadia Ferrari
C’era una volta un compleanno, un gruppo di persone sconosciute fra loro ma legate dall’amicizia al festeggiato. C’erano ricordi, intrecci, buoni piatti, abbracci. E c’era uno zainetto zeppo, dal quale uscirono “i libroni”, dono sperato quanto inatteso, che mi ha reso felice! C’erano i luoghi in cui ci hai ospitato: piazzale della Vetra, le stradine del centro, del bel racconto e la passeggiata per quella Milano, a cavallo, ancora una volta, tra storie, epoche, affetti.
E ora c’è il romanzo!
Il tuo primo romanzo, Igor, si legge in un fiato, è bello, molto bello! L’ho letto assaporandone tutte le parti nel loro intrecciarsi di tempi: il romanzo infatti attraversa tre generazioni di padri. Il passaggio dei tempi è perfetto, il romanzo scorre avanti e indietro con scioltezza e rigore. I nessi sono chiari. Non da meno sono gli intrecci di sguardi e di ruoli: la storia si dipana tra dimensioni intime/familiari e storico/sociali che narrano contemporaneamente il padre, il figlio, lo scrittore, il pedagogista e l’amico. Mi pare che tu sia perfettamente riuscito a tessere i significati pedagogici che da tempo cerchi di insegnare, senza mai cedere il passo al maestro. Una bella sfida, difficile per te.
La modalità di scrittura e i temi trattati scorrono fluidi tra le pagine, assieme ai personaggi, ben dipinti che quasi sembra di conoscerli, coinvolgendo il lettore intimamente e profondamente nelle vicissitudini di un passato storico patrimonio di tutti e nelle traversie della famiglia Spadario. La guerra fa da sfondo a tutta la narrazione a più livelli. Infatti il romanzo si snoda principalmente nella Milano della seconda guerra mondiale, nella travagliata fase del dopo armistizio dal 43 al 45. In cui comincia, tuttavia, una nuova battaglia, che per una parte sarà quella della Resistenza tesa alla liberazione del paese, per un’altra quella della fedeltà alla barbarie del nazifascismo, collegandosi poi ai primi del ‘900 per poi giungere sino a oggi.
Dentro a questo sfondo si dipanano le traversie di una famiglia di origini siciliane, appunto gli Spadario che, di generazione in generazione per volontà dei padri, e sempre in fuga da un segreto, impediscono ai figli di mettere radici. Meravigliosi i passaggi in cui sottolinei come la cultura famigliare possa porre limiti tanto oscuri quanto fermi alla ricostruzione della genealogia, tanto che il silenzio diviene l’unica possibilità di essere ricordati, dando origine al paradosso che poi attraversa tutta la narrazione:
“… irrompeva in mezzo a loro con quella domanda da non farsi. Una domanda che da ore stavano accuratamente evitando di porsi, cresciuti com’erano nella sottile disciplina dell’evitare domande d’ogni tipo, specie se riguardavano cose di famiglia.”
“Cos’era successo? E cosa era successo al loro papà uscito il giorno prima e non ancora tornato? Questo dicevano i loro sguardi. Questo tacevano le loro bocche. Piccoli, ma avevano già imparato a non fare domande.” (capitolo 1 Scomparso)
La storia vera e il romanzo si intrecciano, regge anche la tensione che hai tenuto sul segreto e regge sino alla fine. Il romanzo racconta della custodia di un segreto familiare maledetto, una vergogna… anch’io serbo dolorosamente questa stessa prerogativa. Una realtà quella dell’occultazione della memoria abbastanza comune alla generazione dei nostri genitori che in generale non hanno voluto o saputo raccontare, perdendo di vista l’importanza e impedendo ai figli di dare forma alla propria identità e sentirsi meno soli. Un tema attuale quindi in cui molti potrebbero riconoscersi. Una realtà che, forse, appartiene ancora largamente anche alla nostra epoca. Io stessa, leggendo, mi sono accorta che perpetuo lo stesso errore.
“… Il vuoto di cui mi hai riempito ha mandato al macello la mia volontà e il mio impegno in innumerevoli trincee. Senza una storia, senza una cultura di riferimento, senza patrimonio, senza conoscenze, ho assaltato alla baionetta la vita che non si è nemmeno presa la briga di falciarmi con la mitragliatrice: si è limitata ad ignorarmi. La volontà e l’impegno non bastano, papà. Ci vuole un’eredità e tu me l’hai negata.” (capitolo 9 L’eredità negata)
Quanti intrecci con quello che siamo e siamo stati ho ritrovato nel racconto. Come sai, anch’io vivo nell’oblio del passato, con forse una responsabilità maggiore: io non ho mai cercato di sapere perché alle poche cose che mi sono state raccontate non ho mai attribuito grande valore. Ancora oggi rimango orfana e fatico a ritrovare segni di una qualsiasi eredità. Identificare un’eredità, soprattutto a livello parentale, richiede un lungo lavoro di riconoscimento delle proprie radici e di riconoscenza per chi ce le ha consegnate. Un lavoro, che come vien ben descritto nel romanzo, passa anche attraverso l’inquietudine di dover accettare i misteri, di provare a violare i terreni dell’indicibile che spesso le famiglie regalano, misurandosi con la custodia dell’ambivalenza… che (si sa) viene poco tollerata dall’animo umano. Lavoro non scontato e certo non esente da fatica.
Infine vorrei dirti del sottile dispiacere che mi ha provocato e poi accompagnato per tutto il libro, la scelta di raccontare parti occulte della Storia. C’è il rischio di identificarsi con Domenico e Angelo tanto da percepire l’adesione al fascismo come scelta giusta e il contrario come rivolta gestita da un manipolo di balordi… In alcuni momenti la narrazione di avvenimenti e contenuti di violenza, per lo più atti individuali, reazioni alla barbarie o addirittura errori, sembrerebbero mettere in risalto “luci e ombre” della Resistenza, questione tuttora bollente. Non ti nascondo Igor il timore di questa deriva, così potrebbe essere interpretato dai più e dai giovani che leggeranno il romanzo.
Ma forse è solo un mio timore e fa parte della personale resistenza a far morire l’unico mondo che i miei genitori sono riusciti a costruirmi attorno per fortuna dalla parte dei “giusti”. Un mondo che so essere fatto di miti e di eccessi, esattamente come il suo contrario, ma che non mi sento di paragonare. Quindi non lascerò che si dissolva facilmente. Preferisco pensare al tuo intento di mettere in risalto i danni che strategie di evitamento hanno prodotto in una parte di mondo che a quel tempo ha scelto di non reagire. O meglio non ha scelto proprio nulla. Nel racconto ci sono segni che vanno in questa direzione e non lasciano dubbi.
“C’era una guerra da dimenticare. Soprattutto c’era da dimenticarsi di essere stati dalla parte sbagliata della Storia e dunque la negazione del passato sembrava avere motivazioni solide” (capitolo 9 L’eredità negata)
Ciò nonostante quest’ultima questione mi turba e resta aperta come curiosità.
Leggendo emerge lentamente e inesorabilmente nell’intreccio complesso delle parti il tema centrale del romanzo che è di tipo squisitamente educativo. Il testo riesce in modo compiuto a tessere una verità conosciuta quanto dimenticata: l’importanza di lasciare agli eredi una testimonianza affinché si possa consegnare una storia, vergognosa che sia, accompagnandoli nella responsabilità di attribuirle un senso. Assumendosi così il compito di comprendere cosa fare della storia che ci si ritrova in mano per poterla riconsegnare al futuro. Unica chance di sopravvivenza.
Emozionante, quanto molto dura, la testimonianza di Domenico (il padre della generazione di mezzo) in tutto l’ultimo capitolo Canto di morte:
“Un uomo deve lasciare un segno di sé, se non vuole limitarsi a essere un fiore.”


 L’eredità spezzata è sia un libro cartaceo, sia un ebook. Può essere acquistato su
L’eredità spezzata è sia un libro cartaceo, sia un ebook. Può essere acquistato su