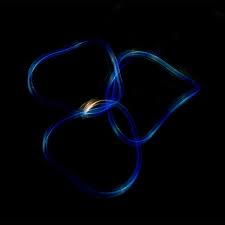di Irene Auletta
A periodi alterni mi ritrovo a ragionare sulla cura e sulle sue molteplici sfumature che sovente mi restituiscono forte il colore del clima culturale in cui siamo immersi.
La mia analisi da anni va oltre le singole persone o professioni e si rivolge all’idea o alle idee di cura dominanti che producono effetti e sbavature che osservo come totale disattenzione, laddove vedo mani addosso che si traducono sia concretamente e materialmente con un’invasione verso il corpo dell’altro, sia con quei comportamenti che prendono la forma del non riconoscimento dell’altro, del “passargli sopra”, dell’interferire con lo spazio vitale ed esistenziale, della persona e della sua identità.
Quando penso alla cura penso inevitabilmente ai gesti e ai linguaggi che l’accompagnano e penso a come sia importante continuare a riconoscerli, esplicitarli e nominarli in tutte le espressione contraddittorie che rischiano davvero di inquinare l’idea originaria della cura stessa.
Per questo credo sia importante non spegnere mai i riflettori sui gesti e sulle parole che emergono nelle relazioni di cura, perchè svelano mondi, culture e significati.
In questo periodo sto ragionando molto su alcune parole che sento rivolte a figure adulte, ad esempio in ospedale, senza soluzione di continuità dal personale di assistenza, a quello infermieristico fino a quello medico. Rivolgersi al paziente utilizzando la parola caro o cara, esattamente nel momento in cui il comportamento nega quello stesso significato traducendosi nel non riconoscimento dell’altro e del suo punto di vista. La stessa parola sovente viene utilizzata anche con i parenti dei pazienti e l’altro giorno mi è capitata la stessa cosa anche nel bar dell’ospedale. Sinceramente, non se ne può più!
Ma tutto questo cara, caro cosa vuol dire? Ma de che, potremmo dire in quell’espressione dialettale che, senza voler essere volgare, è rivolta a interrogare un non senso.
A volte vorrei chiederlo, davvero senza polemica e con interesse. Avete fatto tutti lo stesso corso di aggiornamento in cui vi hanno indicato questa direzione e, soprattutto, perchè? Vi hanno forse detto che questo è il modo per stare vicino ai pazienti e ai loro famigliari nel vostro lavoro di cura?
Alcune di queste “abitudini” comunicative le abbiamo sdoganate da anni nei servizi per la prima infanzia e, anche se non sempre si riesce ad essere fedeli ad alcuni principi pedagogici tanto trattati e approfonditi, almeno lì mi pare di incontrare buoni livelli di consapevolezza.
Perchè la vicinanza prevista nelle relazioni di cura tante volte si traduce con parole che esprimono solo una vicinanza di superficie e che appartengono a registri comunicativi e affettivi che riguardano le relazioni d’amore e non le relazioni professionali, che siano medico-paziente o educatore-utente?
Dico questo perchè da anni tratto e cerco di esplicitare come alcune comunicazioni si ritrovino non solo nei servizi che accolgono bambini piccoli, ma anche persone adulte disabili o anziane. Continuo a scriverne proprio perchè il fastidio e la nausea, non portino solo ad una forte intolleranza e malessere ma provino a trasformarsi nella possibilità di tenere aperte riflessioni importanti, quasi vitali.
Tutti e tutte noi che ci occupiamo professionalmente di cura, dovremmo forse periodicamente mettere alcune parole su una metaforica bilancia, accompagnate dalle nostre domande. Cosa significano queste parole per il paziente, per il familiare, per i bambini, i ragazzi e gli adulti che attraversano i servizi sanitari o educativi? Insieme alle parole aggiungerei anche tutti quei gesti di cui ho parlato tante volte che, allo stesso tempo, banalizzano e infantilizzano l’altro.
Vogliamo imparare a dirlo sempre di più tutti, con gentilezza e autorevolezza?
No, Grazie.